 di Andrea Zandomeneghi |
di Andrea Zandomeneghi |
«Ciao, Vanni – ci siamo occupati, qui su ZEST, di Libri da ricordare, scivolati nel dimenticatoio, non più letti, non più editi, fuoriusciti dal discorso letterario, citati ma come ameno-ipotetica (pseudo-ri)lettura, libri che in parte tendono a divenire dei fantasmi. Abbiamo fatto delle scelte molto eterogenee – volendo anche arbitrarie – ma abbiamo anzitutto ritenuto stimolante mappare quasi a campione il territorio dell’onirico, del sacro, del visionario, del mistico, dell’apocalittico, nonché delle loro contaminazioni reciproche: La vita di San Francesco, Paul Sabatier; I Misteri di Eleusi, Albert Hofmann; Scrittori, Antoine Volodine; La mia lotta contro Dio ossia Il libro dei Sette Sigilli, David Lazzaretti; Il libro dei teschi, Robert Silverberg; I diavoli di Loudun, Aldous Huxley.
Cosa pensi di questi testi e soprattutto: a te chi viene in mente che possa essere curioso indagare nella stessa – di per sé vastissima e quasi amorfa – direzione?
«Per me sono tutti libri ben presenti (Silverberg non mi ha lasciato chissà che impressione, però) e nei casi di Aldous Huxley e Albert Hofmann proprio imprescindibili (visto che li citi entrambi, vale la pena ricordare anche il loro carteggio, che Stampa alternativa ha reso liberamente scaricabile come tutti gli storici ‘Mille lire’); d’altra parte non mi sembrano libri che possono avere chissà che circolazione di massa, a parte I diavoli di Loudun, che se vogliamo è anche un romanzo ‘per tutti’.
«Diverso mi sembra anche il caso di Scrittori: Volodine è un autore che solo adesso è arrivato in Italia ed è in una situazione addirittura opposta, non dimenticato ma in fase di scoperta.
«È tuttavia evidente, anche guardando a quelle che sono le novità – parlo degli ultimi dieci-quindici anni, beninteso – più interessanti, che una delle direzioni forti della narrativa contemporanea è quella di un forte ritorno della mistica, della grammatica della visione, della ricerca di nuove metafisiche (vogliamo dire post-materialismo?), in un processo che va già molto oltre la semplice contaminazione tra generi.»
 Per quanto riguarda Volodine, scelsi di inserire Scrittori nella rubrica Ricordare i libri perché – anche in concomitanza con l’uscita di Terminus radioso – si iniziò a verificare un robusto interesse per lui in vari settori del panorama dei leggenti; così proposi come provocazione il suo primo testo pubblicato in Italia, in un’operazione se vogliamo di archeologia del presente – ricordando il per me fondamentale Sebastiano Vassalli. Si trattava cioè di porsi una domanda: come mai la prima opera di Volodine è stata pubblicata così tardi, rispetto alla Francia? Come mai a tutt’oggi di quella copiosa produzione – in alcuni casi anche risalente – in Italia son state tradotte e diffuse solo quattro opere?
Per quanto riguarda Volodine, scelsi di inserire Scrittori nella rubrica Ricordare i libri perché – anche in concomitanza con l’uscita di Terminus radioso – si iniziò a verificare un robusto interesse per lui in vari settori del panorama dei leggenti; così proposi come provocazione il suo primo testo pubblicato in Italia, in un’operazione se vogliamo di archeologia del presente – ricordando il per me fondamentale Sebastiano Vassalli. Si trattava cioè di porsi una domanda: come mai la prima opera di Volodine è stata pubblicata così tardi, rispetto alla Francia? Come mai a tutt’oggi di quella copiosa produzione – in alcuni casi anche risalente – in Italia son state tradotte e diffuse solo quattro opere?
«In realtà capita spesso che un autore, specie se non facilissimo, arrivi ‘tardi’ in questo o quel paese, ma nel caso di Volodine – di Terminus radioso si è parlato molto – sono certo che vedremo tradotto anche il resto della sua produzione.»
 Tu parli di “un forte ritorno della mistica, della grammatica della visione, della ricerca di nuove metafisiche (vogliamo dire post-materialismo?), in un processo che va già molto oltre la semplice contaminazione tra generi” – vorrei chiederti come vedi, come collochi e poni in relazione per meglio dire, rispetto a questo fenomeno la voce che esprimi nei passaggi ambientati nella foresta di Broceliande in Terra ignota. Inoltre: circolano varie e contraddittorie voci sulla derivazione di questo nome, come lo hai costruito o inventato? Più in generale come ti sei relazionato in questo testo dal fortissimo taglio simbolico – di cui non verrà mai lodato abbastanza il finale – con la questione dei nomi, col dare nomi, col generare nomi?
Tu parli di “un forte ritorno della mistica, della grammatica della visione, della ricerca di nuove metafisiche (vogliamo dire post-materialismo?), in un processo che va già molto oltre la semplice contaminazione tra generi” – vorrei chiederti come vedi, come collochi e poni in relazione per meglio dire, rispetto a questo fenomeno la voce che esprimi nei passaggi ambientati nella foresta di Broceliande in Terra ignota. Inoltre: circolano varie e contraddittorie voci sulla derivazione di questo nome, come lo hai costruito o inventato? Più in generale come ti sei relazionato in questo testo dal fortissimo taglio simbolico – di cui non verrà mai lodato abbastanza il finale – con la questione dei nomi, col dare nomi, col generare nomi?
«Non sono sicuro che Terra ignota possa essere utilizzato appieno come esempio di tale tendenza: è del resto, e programmaticamente, un romanzo fantasy. Certo, come ben sai è anche un libro intertestuale, un enorme gioco con tutti i topos (e anche molti singoli elementi che sono stati significativi per la mia propria formazione) del canone fantastico occidentale, ma fin dalla progettazione ho voluto che tale discorso fosse al servizio di una storia avventurosa d’impianto classico, e non viceversa.
«È vero però che, per quanto ne siano state dette cose come ‘‘da Ariosto a Toriyama, passando per Guénon,’’ se lo si legge sotto una certa lente, più attenta agli apparati simbolici che alla vicenda, c’è molto più Guénon che Ariosto o Toriyama, e in effetti il divertimento è stato, ed è, anche mettere così tanto materiale ‘duro’ in un testo che dall’altro lato aderisce appieno a un genere, il fantasy – anzi, l’heroic fantasy – che in Italia, almeno negli ambienti letterari, nessuno prende sul serio.
«Detto ciò, nell’identificare nella ‘parte di Broceliande’ qualcosa che va oltre il fantasy classico per puntare verso quella direzione, vedi giusto. Tutta quella parte è nata dopo il resto del primo libro, non era prevista nello storyboard che mi ero preparato via via che procedevo con la scrittura, e avevo sentito il bisogno di aggiungerla perché a stesura piuttosto avanzata avevo realizzato che ancora al percorso di Ailis mancava una vera crisi, la cattura e la tortura da parte di Åydric Reinhare erano in qualche modo insufficienti, non avevano i tratti della katabasi. Inoltre sentivo che il personaggio di Val aveva un potenziale ancora inespresso, chiedeva spazio e quando i personaggi arrivano a poterlo fare bisogna sempre assecondarli. Così nacque l’idea di lasciargli la scena, cosa che subito mi portò a confrontarmi con questioni di grande interesse: un mondo ‘fatto per gli eroi’, per gente ‘larger than life’, cos’è, come si presenta, a un uomo normale? Certamente come molto più pericoloso; e certamente i suoi codici, che in qualche modo sono l’inevitabile pane quotidiano di una figura messianica come Ailis, per un uomo normale diventano la manifestazione di spaventose metafisiche – e, paradossalmente, incrementano la loro sostanza.
 «Circa i nomi, dici bene, sono un elemento cruciale di Terra ignota: quando si lavora a un fantasy c’è sempre in ballo la questione della lingua di quel mondo, e l’ombra del magistero di Tolkien, rispetto al quale si può provare a competere (perdendo), al quale ci si può accodare (imitandolo) o che si può ignorare muovendosi un po’ alla buona (e finendo a scrivere uno dei troppi fantasy alla Aldo, Giovanni & Giacomo, con nomi tipo Kroll figlio di Gnur, arcimago Klarork e bubbole varie). Oppure, come ha già fatto con successo Martin, si può giocare al ribasso: pensa ai suoi nomi di luoghi improntati alla massima semplicità concettuale (King’s Landing, Winterfell) o di persone modulati giustapponendo un nome davvero molto ordinario a un cognome ‘più fantasy’ (Robert Baratheon, Ned Stark)… Io ho scelto un principio affine – nel dubbio, rasoio di Occam e pedalare – ma combinandolo con un sistema di rimandi simbolici o intertestuali analogo a quello delle figure e dei temi del libro; nel caso della foresta magica, era inevitabile andare lì visto che il ciclo arturiano è comunque la prima radice di Terra ignota. Circa la traslitterazione, dopo aver selezionato tutti i nomi di persone, luoghi e cose della saga, ho operato un’azione di uniformamento, cercando di renderli più coerenti possibili tra loro, come se appartenessero a un unico sistema fonetico, e così è venuta fuori la dicitura che si trova nei due romanzi.»
«Circa i nomi, dici bene, sono un elemento cruciale di Terra ignota: quando si lavora a un fantasy c’è sempre in ballo la questione della lingua di quel mondo, e l’ombra del magistero di Tolkien, rispetto al quale si può provare a competere (perdendo), al quale ci si può accodare (imitandolo) o che si può ignorare muovendosi un po’ alla buona (e finendo a scrivere uno dei troppi fantasy alla Aldo, Giovanni & Giacomo, con nomi tipo Kroll figlio di Gnur, arcimago Klarork e bubbole varie). Oppure, come ha già fatto con successo Martin, si può giocare al ribasso: pensa ai suoi nomi di luoghi improntati alla massima semplicità concettuale (King’s Landing, Winterfell) o di persone modulati giustapponendo un nome davvero molto ordinario a un cognome ‘più fantasy’ (Robert Baratheon, Ned Stark)… Io ho scelto un principio affine – nel dubbio, rasoio di Occam e pedalare – ma combinandolo con un sistema di rimandi simbolici o intertestuali analogo a quello delle figure e dei temi del libro; nel caso della foresta magica, era inevitabile andare lì visto che il ciclo arturiano è comunque la prima radice di Terra ignota. Circa la traslitterazione, dopo aver selezionato tutti i nomi di persone, luoghi e cose della saga, ho operato un’azione di uniformamento, cercando di renderli più coerenti possibili tra loro, come se appartenessero a un unico sistema fonetico, e così è venuta fuori la dicitura che si trova nei due romanzi.»
Se non sbaglio una volta avesti a dire che un genio letterario innato e naïf – senza basi culturali solide e senza letture alle spalle – può risultare bravissimo e scrivendo nel proprio registro, ma difficilmente può produrre letteratura di genere, perché non ne conosce i sottocanoni. Ecco, io credo che non si possa oggi scrivere un fantasy veramente rilevante senza aver pienamente digerito entrambi gli autori che tiri in ballo: Tolkien e Martin; quindi interpreto la tua affermazione relativa “all’ombra del magistero di Tolkien, rispetto al quale si può provare a competere (perdendo), al quale ci si può accodare (imitandolo) o che si può ignorare” nel senso che, in riferimento alla lingua del mondo fantasy creato, si può certamente ignorare l’immane e impervio edificio della lingua elfica (dotata non solo di proprie parole o al limite di suffissi e prefissi ricorrenti, come in Martin, ma anche di una propria grammatica completa, operativa e funzionante e addirittura di proprio sistema di grafemi; una lingua che peraltro preesiste rispetto ai suoi utilizzi narrativi, proprio a livello della biografia dell’autore, e che si fonda anche molto sulla spropositata energia della sua configurazione mentale ossessivo compulsiva e quindi spiccatamente nevrotica, una forma di energia semplicemente preclusa agli altri, inattingibile – rectius: ovvio che altri autori abbiano attinto all’energia ossessiva de qua, ma per plasmare edifici di tutt’altro tipo) e dei suoi dialetti; ma lo si può ignorare, questo edificio, dicevo, solo essendo consapevoli della sua esistenza e consistenza: si può ignorare Tolkien, a patto di aver metabolizzato Tolkien, se si vuol scrivere un fantasy. Non so se su questo concordi – è il mio pensiero e potrei aver travisato le tue parole, dimmi tu.
«La penso esattamente come te.»
Ultroneo sarebbe in questa sede mettersi ad analizzare l’opera di Martin, di cui sono molto appassionato e che ho molto amato; ma ci sono due aspetti che mi interessano: Le cronache del ghiaccio e del fuoco iniziano probabilmente a degenerare con la comparsa della linea narrativa di Davos, ma rovinano del tutto col quinto libro (A Dance with Dragons, ovvero – dato lo spezzettamento delle edizioni italiane – I guerrieri del ghiaccio), quando cioè l’autore muta la sua prosa – prima totalmente strumentale alla narrazione e priva di ambizioni formali alte – e decide di adottare uno stile più elevato e ricercato con velleità letterarie (esemplare in questo senso il primo capitolo del libro de quo: Tyrion che attraversa il Mare Stretto ubriacandosi di continuo – da lì in poi c’è ben poco da salvare; l’eccezione che mi viene in mente è Cersei umiliata che cammina nelle strade di Approdo del Re).
«Ecco, tu invece arrivi a Terra ignota con una padronanza stilistica e uno spessore letterario molto elevati, sviluppati e consapevoli; e se è vero che adotti per i nomi (il migliore – rectius: quello che ho preferito e che mi s’è ficcato in testa – è Åydric Reinhare, ma anche Vevisa non scherza) un principio “affine” a quello di Martin, in virtù del rasoio di Occam, certamente non “giochi al ribasso” però dal punto di vista dell’elaborazione simbolica (crei una metafisica complessa e ricca di rimandi interni e non mi riferisco tanto alla questione degli elementi, né agli aspetti vedici, soma su tutti, quanto al Sogno e al sonno dell’Imperatrice, alla Spada, alla Coppa et coetera) e di quella formale: lessico, espressioni idiomatiche, sintassi, punteggiatura (l’utilizzo dei due punti che fai, ad esempio, è molto contemporaneo e autoriale, non lo si riscontra in altri testi fantasy) costruzione dei capoversi et similia. La mia domanda è: quali direttive ti sei dato in riferimento allo stile? quali limiti alla ricercatezza e complessità formale ti sei imposto (l’esempio più sciocco ma anche più evidente è l’uso di forme arcaizzanti, che padroneggi, ma che nel testo inserisci – perché ci sono – calibrando e modulando molto)?
«Un altro dei rischi tipici del fantasy poco ponderato è quello di pensare di cavarsela a suon di ‘messere’, ovvero adottando parole medievaleggianti o arcaiche affidando a esse la funzione di ‘creare atmosfera’, il che però, se fatto senza un’opportuna riflessione genera solo manierismo, un effetto che ricorda più la festa medievale a Monteriggioni che altro. C’è da considerare poi anche il fatto che un libro è scritto nella lingua in cui scrive l’autore, la quale, oltre che moderna, è proprio diversa da quella in cui parlano i personaggi: tutti i dialoghi di un fantasy sono sempre, se vogliamo, ‘tradotti’, mentre i nomi sono riportati o – se, come è probabile, in quel mondo vige un differente alfabeto – traslitterati. La semplicità aiuta allora anche a sbrogliare meglio tali questioni.
 «In generale, al di là delle considerazioni sulla lingua fatte sopra e da te ribadite, credo che la linea da seguire sia quella di cercare una mimesi, necessariamente astratta, non tanto rispetto a come ci immaginiamo che potrebbero ragionare e parlare eroi di tempi mitici, ma anzitutto in opposizione a come certamente non parlerebbero. È qualcosa che si vede bene in quelli che finora sono generalmente considerati gli unici due veri capolavori del cinema fantasy, Excalibur di Boorman e Conan il barbaro di Milius: il segreto di entrambi è che i personaggi, pur senza finire nell’astruso, si esprimono e pensano secondo linee non aderenti all’oggi, creando una scollatura che, visto il contesto, finisce per generare credibilità»
«In generale, al di là delle considerazioni sulla lingua fatte sopra e da te ribadite, credo che la linea da seguire sia quella di cercare una mimesi, necessariamente astratta, non tanto rispetto a come ci immaginiamo che potrebbero ragionare e parlare eroi di tempi mitici, ma anzitutto in opposizione a come certamente non parlerebbero. È qualcosa che si vede bene in quelli che finora sono generalmente considerati gli unici due veri capolavori del cinema fantasy, Excalibur di Boorman e Conan il barbaro di Milius: il segreto di entrambi è che i personaggi, pur senza finire nell’astruso, si esprimono e pensano secondo linee non aderenti all’oggi, creando una scollatura che, visto il contesto, finisce per generare credibilità»
L’altro aspetto di Martin che mi interessa è il suo restituire organi genitali, foie e deiezioni (in Tolkien ad esempio non solo non si copula, né si parla di sesso, ma non si defeca e orina neppure – il che per altro è perfettamente coerente con un certo tipo d’impronta cavalleresca dell’opera sua) ai personaggi. Il recupero del basso e del carnascialesco; l’erotismo che spesso diviene motore primo dell’azione (l’incesto Lannister, la causa della morte del giovanissimo Re del Nord, tutta la vicenda di Tyrion e della prostituta et coetera). Questo recupero lo fai anche tu (non tanto del carnascialesco di per sé: in Martin c’è più Petronio e più Gargantua e Pantagruel, per intendersi; quanto della dimensione erotica), basta ricordare la vicenda di Vevisa posseduta da H. H. Gran Maestro del Cerchio d’acciaio, o ancora meglio – perché è uno (forse Lo) snodo cruciale – il rapporto omo tra Ailis e Brigid prodromico allo scioglimento finale. A me sembra che tu abbia deciso di tener conto e utilizzare l’eros e le perversioni lubriche (sempre in riferimento ai membri del Cerchio d’acciaio: stuprare bambini di ambo i sessi), ma senza pervenire al realismo crudo minuziosamente descrittivo della genialità e dell’amplesso, come avviene tra i tantissimi in P. Roth (Il teatro di Sabbath) o in B. E. Ellis (Glamorama, la scena pornografica del triangolo), cioè nella letteratura non di genere . Due domande: come ti sei regolato su questo punto, cioè sul mostrare la sessualità, ovvero quali direttive ti sei dato? Inoltre, abbiamo visto che hai “forzato” – e quindi innovato – il sottocanone fantasy con la parte di Brocelilande in riferimento alla grammatica della visione, credi che il realismo sessuale e genitale possa essere spinto sensatamente nel fantasy con ancor maggiore forza in un’operazione di recupero nella letteratura di genere di sempre più vasti territori del paesaggio antropico in tutte le sue manifestazioni, articolazioni e declinazioni?
«Intanto, come si può notare anche dal fatto che tutti gli esempi che citi appartengono a Terra Ignota 2, ho scelto due approcci molto diversi per i due volumi che compongono la vicenda (il terzo, in uscita a fine 2017, sarà un prequel autonomo, ambientato in un contesto completamente diverso – e presumibilmente ‘‘immaginario’’, laddove il mondo di Terra Ignota si dà per ‘‘vero’’ – che racconterà, di fatto, le origini dell’Imperatrice): nel primo, che è costruito anche come un sistema di rimandi alla fiaba – Morfologia della fiaba di Propp è stato uno dei testi teorici di riferimento, al pari del Ramo d’oro di Frazer e prima dell’Eroe dai mille volti di Campbell, di Simboli della scienza sacra di Guénon  e di Magick di Crowley – non c’è la benché minima rappresentazione del sesso, il fatto che H.H. sia attratto da Vevisa e per questo non la liquidi immediatamente lo si intuisce tra le righe, mentre i rapporti tra Ailis e Val, che pure generano anche un bel po’ di gelosia da parte di Brigid, vengono sempre glissati pudicamente con quella che nel cinema di qualche decennio fa sarebbe stata la più classica delle ‘inquadrature sul focolare’. Il secondo libro, invece, ha un tono opposto, più adulto e oscuro – lo si vede fin dalla copertina e dal suo aprirsi con un eccidio, laddove Terra Ignota 1 aveva un prologo ariostesco seguito da un avvio dell’azione in uno scenario bucolico – e quindi si poteva, anzi era necessario, indulgere maggiormente in certi dettagli, ma senza bizantinismi giacché quello delle Terre Occidentali è comunque un mondo di gente pratica e spiccia. Sarebbe stato interessante magari esplorare la sessualità di Åydric Reinhare, peccato non sia arrivato vivo al secondo volume…»
e di Magick di Crowley – non c’è la benché minima rappresentazione del sesso, il fatto che H.H. sia attratto da Vevisa e per questo non la liquidi immediatamente lo si intuisce tra le righe, mentre i rapporti tra Ailis e Val, che pure generano anche un bel po’ di gelosia da parte di Brigid, vengono sempre glissati pudicamente con quella che nel cinema di qualche decennio fa sarebbe stata la più classica delle ‘inquadrature sul focolare’. Il secondo libro, invece, ha un tono opposto, più adulto e oscuro – lo si vede fin dalla copertina e dal suo aprirsi con un eccidio, laddove Terra Ignota 1 aveva un prologo ariostesco seguito da un avvio dell’azione in uno scenario bucolico – e quindi si poteva, anzi era necessario, indulgere maggiormente in certi dettagli, ma senza bizantinismi giacché quello delle Terre Occidentali è comunque un mondo di gente pratica e spiccia. Sarebbe stato interessante magari esplorare la sessualità di Åydric Reinhare, peccato non sia arrivato vivo al secondo volume…»
Come tuo lettore son molto felice tu stia scrivendo il terzo tomo di Terra ignota, sono poi lieto del fatto che si tratti di un prequel e non di un sequel, dato l’eccellente vigore recisivo – ho già avuto modo di esprimere quanto lo apprezzi – del finale di Terra ignota 2. Nella tua intervista all’Avanti dici della tua opera che “in un binario parallelo, poi, ci sono i romanzi fantasy, i quali però col terzo volume, in arrivo nell’autunno 2017, vedranno un collegamento con la mia produzione realistica” e prima m’hai detto che nel terzo volume tratterai delle “origini dell’Imperatrice”. “Produzione realistica” + “origini dell’Imperatrice” = tanta carne al fuoco. Non voglio strapparti anticipazioni; immagino che la questione del Sogno sarà uno snodo cruciale, anche perché quel mondo che hai raccontato – e che sarà trattato come “dato” – è proprio creato e realizzato dal Sogno dell’Imperatrice; si sogna solo dormendo e si potrebbero aprire i mille rivoli dello stato di coscienza onirico, delle più o meno solide scoperte delle neuroscienze, del patrimonio di conoscenza, suggestione e soprattutto esperienza che abbiamo a riguardo, delle allucinazioni e delle paralisi ipnagogiche e così via; non mi stupirebbe – per assurdo – che l’Imperatrice fosse la figlia di Iacopo Gori o che tu facessi sulla ghiandola pineale, l’ipofisi, il lavoro che fa Cărtărescu sull’amigdala o la corteccia cerebrale; come non mi stupirebbe l’utilizzo della ricchissima ontologia stratificatasi progressivamente nel subcontinente indiano, del concetto di samsara, del dispositivo narrativo posto in essere da Hesse nel Gioco delle perle di vetro, appendice Una vita indiana: voglio proprio vedere come te la giochi con questo libro. Ti faccio una sola domanda: sarà ascrivibile all’etichetta da te utilizzata per definire i primi due volumi, ovvero “l’heroic fantasy”? Corollario: dato il “collegamento” con la tua “produzione realistica” avremo un nuovo Santoni HG o un nuovo Santoni-e-basta (nella mia libreria Terra ignota sta nella sezione letteratura italiana, non nella sezione fantasy – e questo avviene per ben precisi motivi che non sto ora a sbrodolare)?
«Sei perspicace, infatti hai già detto quasi troppo. Mi limiterò dunque a chiosare. Il collegamento è al livello di radicalità che immagini, ma non sarà Iacopo Gori il suo ‘arcano maggiore’: Iacopo è, rispetto a questo primo blocco della mia produzione, lo yang, e infatti governa Muro di casse, che è un romanzo che ha in sé elementi di memoir e di reportage – di realtà ‘dura’. Per un’operazione del genere ci vuole invece lo yin, e dunque la scena sarà tutta per 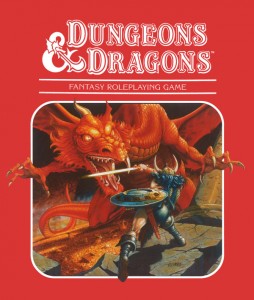 Federico Melani, il Mella, esattamente come, per un campo intermedio quale sarà La stanza profonda, il mio romanzo ambientato tra i giocatori di ruolo, in uscita per Laterza questa primavera, ho scelto il Paride, l’incompiuto (o Appeso che dir si voglia). Circa il genere: non sarà un ‘heroic fantasy’, bensì, volendo usare appunto le etichette, un ‘urban fantasy’ a ogni effetto. Per la stessa ragione non so se apporre il morselliano HG, ma al momento propendo per il sì»
Federico Melani, il Mella, esattamente come, per un campo intermedio quale sarà La stanza profonda, il mio romanzo ambientato tra i giocatori di ruolo, in uscita per Laterza questa primavera, ho scelto il Paride, l’incompiuto (o Appeso che dir si voglia). Circa il genere: non sarà un ‘heroic fantasy’, bensì, volendo usare appunto le etichette, un ‘urban fantasy’ a ogni effetto. Per la stessa ragione non so se apporre il morselliano HG, ma al momento propendo per il sì»
Prescindendo da Artemidoro, Freud e compagnia bella, vorrei che mi parlassi del tuo rapporto con i tuoi sogni: sogni molto? Hai mai assunto melatonina – integratore da banco – per stimolare l’attività onirica impigrita? I tuoi sogni ti interessano? Li consideri diarree del cervello che non vanno prese sul serio? Prendi appunti, usi un diario? I tuoi sogni sono mai stati lo stimolo immaginifico ingravidante primo che poi con il lavoro e la disciplina t’ha portato a partorire un’opera o un capitolo o una scena
«Di fronte a sittanto intuito (a meno che non te l’abbia detto in altra occasione, l’abbia dimenticato e ora tu me lo rivenda spacciandoti per veggente) credo che sia bene giocare a carte scoperte: Il delegato d’argilla – questo il titolo di lavorazione di tale ‘Terra ignota zero’, che cambierà sicuramente ma che tiro fuori perché al momento (lo sto scrivendo proprio ora) mi rapporto al libro così e mi è impossibile chiamarlo diversamente – nasce proprio dalla trascrizione integrale di un sogno. Lo feci a Londra, durante un soggiorno nell’autunno 2010, e la sua sostanza spiccatamente diversa dal solito mi persuase a prenderne nota su un taccuino, cosa che faccio molto raramente (solo i giovanissimi pensano che il sogno abbia molte qualità in comune con la visione). Prima di farne il libro che in qualche modo sentivo ne sarebbe potuto uscire, ho dovuto attendere sei anni. Circa la melatonina: l’ho provata un paio di volte perché anni fa avevo una fidanzata che ne era ghiotta, ma non ho percepito incrementi apprezzabili nell’attività onirica.»
Mi spaccio volentieri da veggente, pur essendo un insulso e patibolare timoniere del Battello Ebbro, ma in questo caso non mi avevi detto nulla “in altra occasione” – intuizione, come si suol dire. Mi piacerebbe una volta per tutte capire esattamente cosa è 999 rooms. È il tuo “nuovo sketchbook”. Ok. Ma come funziona, come lo usi, perché è in inglese, perché è in versi e non in prosa? Inoltre: esiste la possibilità che tu nel futuro dia alle stampe un testo in versi?
«Sono, o meglio saranno dato che non è ancora finito e passeranno molti anni prima che lo sia, 999 testi poetici a forte tasso di intertestualità e pastiche, divisi in 33 sezioni di 33 testi ciascuna; per ora ne ho ultimate cinque, le Rooms of innocence, le Rooms of experience, le Rooms of memory, le Rooms of desire e il Dream of the blue room, e sto per finire le Rooms of the night, a cui seguiranno quelle del giorno e quelle del crepuscolo. 999 rooms è in inglese perché per me la lingua della poesia – per quanto possa ammirare, mettiamo, il succitato Rimbaud, Pessoa, Bachmann, Zanzotto – per citare poeti che scrivono nelle lingue che riesco bene o male a capire, è l’inglese. Tutto per me è cominciato con l’inglese: certo, leggevo; certo, c’erano molti libri in casa; ma la mia apparizione, esattamente come per Ginsberg, fu quella di William Blake. Non mi apparve nella notte davanti al letto, mi limitai a trovarlo nell’antologia d’inglese per il liceo, ma scattò qualcosa di profondo. Il tutto sarebbe esploso dopo anni, ma fu lì, e subito dopo, sempre grazie a quel testo scolastico, con la vertigine della Wasteland di Eliot e del perne in a gyre della Sailing to Byzanthium di Yeats, nonché delle trincee e del gas (Quick, boys!…) di Wilfred Owen, che ebbi per la prima volta l’idea di che cosa enorme, esaltante, fosse la letteratura. Così, l’inglese. Forse c’entra anche una forma di pudore: visto che sono prosatore e non poeta, affidando la mia poesia a un’altra lingua magari spero mi sia riservata maggior indulgenza. Invero, proprio in virtù dell’apprezzamento di poeti che stimo molto quali Alessandro Broggi e Marco Giovenale, ho sottoposto le 999 rooms alla lettura di alcuni dei maggiori poeti e critici di poesia italiani, incontrando un inaspettato consenso: l’apprezzamento di Buffoni, che traduce Keats (solo per dirne uno), mi ha onorato e sorpreso; Guido Mazzoni mi ha suggerito, per l’appunto, di pubblicarle, mai io non so niente di editoria poetica e ho molti libri di prosa in programma, perciò preferisco starmene pudicamente sottoterra. A febbraio faremo un e-book con GAMMM, proprio su proposta dei suddetti due poeti, e per ora mi va bene così. Tematicamente, invece, credo che la nuova direzione dei miei “sketch” rispetto a Personaggi precari, indichi una maggior attenzione a temi metafisici e, appunto, legati all’intertestualità – ci sono pochissimi personaggi, là dentro.»
Per l’avvenire, quali forme credi possa assumere quella che tu chiami la tua “attività collettiva” (iniziare a scrivere su una rivista autoprodotta, il Baggio con Salimbeni, l’avventura di SIC e In territorio nemico)? Cosa ti interesserebbe perseguire e realizzare su questo fronte e perché? Ti chiedo inoltre: a quale esigenza profonda risponde questa tua componente “collettivistica e collaborativistica”? Credi ad esempio che afferisca alla problematica cruciale dell’altro e dell’alterito magari a una consapevole sensibilità politico-culturale tradizionalmente c.d. di sinistra (escludo a priori la matrice della dottrina sociale cattolica; ma in caso correggimi pure in malo modo)? Io poi l’ho chiamata esigenza, come fosse un bisogno invece potrebbe piuttosto trattarsi di un impegno che ti imponi per plasmarti in base alla tua concezione dell’uomo e della realtà.
 «Le basi sono quelle che dici, ho cominciato a scrivere in una rivista come Mostro, autoprodotta e nata in seno a esperienze di movimento, in cui le riunioni di redazione erano la vera vita della rivista stessa, e perciò ho sempre visto la letteratura anche come un’attività sociale. Credo che la mia ‘attività collettiva’ si esprima oggi appieno in ciò che faccio per Tunué: stabilire e governare una linea editoriale, trovare talenti, lavorare con loro al testo, pubblicarli, gestire dinamicamente detta linea in base a ciò che via via pubblichiamo. Giunti a questo punto non so se c’entra la politica, al massimo quella editoriale nel mio cercare il più possibile testi fuori dalle linee più facili… Forse in questo caso specifico la spiegazione è più psicanalitica, ho faticato abbastanza per esordire, e poi per arrivare a un editore importante, con intoppi di ogni genere sul percorso, così quando vedo un giovane di talento e innamorato della letteratura mi viene naturale e mi dà piacere fare quel che posso per risparmiargli i travagli che ho passato io. E poi mi interessano più i libri degli altri dei miei»
«Le basi sono quelle che dici, ho cominciato a scrivere in una rivista come Mostro, autoprodotta e nata in seno a esperienze di movimento, in cui le riunioni di redazione erano la vera vita della rivista stessa, e perciò ho sempre visto la letteratura anche come un’attività sociale. Credo che la mia ‘attività collettiva’ si esprima oggi appieno in ciò che faccio per Tunué: stabilire e governare una linea editoriale, trovare talenti, lavorare con loro al testo, pubblicarli, gestire dinamicamente detta linea in base a ciò che via via pubblichiamo. Giunti a questo punto non so se c’entra la politica, al massimo quella editoriale nel mio cercare il più possibile testi fuori dalle linee più facili… Forse in questo caso specifico la spiegazione è più psicanalitica, ho faticato abbastanza per esordire, e poi per arrivare a un editore importante, con intoppi di ogni genere sul percorso, così quando vedo un giovane di talento e innamorato della letteratura mi viene naturale e mi dà piacere fare quel che posso per risparmiargli i travagli che ho passato io. E poi mi interessano più i libri degli altri dei miei»
Abbiamo visto come in Terra ignota ci sia uno snodo cruciale di carattere omo, la qual cosa non è di per sé interessante (senza andare lontano, nel fantasy abbiamo Loras e Renly in Martin); diviene invece curiosa se inserita all’interno della tua opera complessiva, perché nella tua produzione un accenno, un accadimento, un rimando, un personaggio omo è sistematicamente presente: Domenico in Personaggi precari, il capodanno tremendo con la perlina che passa da una bocca all’altra in Gli interessi in comune, Alfonso e i gambrini in Se fossi fuoco arderei Firenze, lesbismo in Muro di casse e così via. Siccome sei un autore molto consapevole e non scrivi – o comunque non pubblichi – mai nulla per puro caso ti volevo chiedere il motivo di questa scelta sistematica: operazione di marketing: ampliare il proprio pubblico? Operazione politica: contribuire allo sviluppo di un immaginario, di un’antropologia e di una sensibilità che dissolvano alcuni tratti biechi della mentalità c.d. tradizionale? Inginocchiarti dinnanzi al politicamente corretto? Abbracciare – in un’operazione estetico-narratologica – l’intero spettro della fenomenologia umana? Mimesi del reale che vivi e che ti circonda?
«Escludendo in toto il primo punto – non si deve mai scrivere pensando a un pubblico o, peggio che mai, ad ampliarlo – e ovviamente il terzo (non mi interessa minimamente il politicamente corretto), gli altri mi paiono tutti sensati. In realtà mi viene abbastanza naturale, quindi forse l’ultima delle possibili motivazioni che adduci è quella più rilevante, un po’ come quando mi chiedono del precariato: nei miei libri realistici ci sono tanti cosiddetti precari perché ne ho tanti intorno e tanti ne vedo nel mondo, non per chissà che piano politico – piano che pure in questo caso che evochi condividerei appieno dato che le distinzioni di genere mi fanno orrore.»
Uno scenario particolarmente interessante a mio giudizio è quello francese, da François Rabelais a Pierre Klossowski, passando per Paul Bourget, le opere meno note di Joris-Karl Huysmans e André Gide. Come siamo messi ‘a francesi’ in Italia, a livello editoriale, a livello di diffusione, a livello di reale lettura, lettura concentrata e attiva? Ad esempio, c’è qualcosa di Arthur Rimbaud che si legge meno o poco o per nulla?
«Male sicuramente. Citi Gide, quanti oggi in Italia leggono Gide?
«Ora, è vero che Carrére, Ernaux, Houellebecq, Littell sono molto letti e hanno riportato attenzione sul romanzo francese contemporaneo, e ultimamente anche autori come Deck, Echenoz, Énard e Volodine mi pare abbiano trovato delle nicchie importanti di lettori, ma chi legge, che so, Laurent Mauvigner? Che peso ha in Italia Laurent Binet? E sto citando autori relativamente giovani ed emersi con grande forza in patria: se ci si sposta all’indietro ci sono dei buchi impressionanti, che arrivano fino a autori di statura assoluta – chi legge più Henri Michaux in Italia? Io stesso l’ho scoperto da poco, e mi sono reso conto di quanto sia imprescindibile –, dunque figurarsi quelli ‘solo’ molto buoni: non si vedono mai, è difficile anche solo venire a contatto con essi, a meno di occuparsi specificamente di letteratura francese. Pensa – sono esempi personali, ovvio, e solo i primi che mi vengono in mente, ma credo che diano il polso della situazione generale – che un Millet lo scoprii grazie all’Inferno del romanzo, un saggio per epigrammi (da noi uscì per Transeuropa sei anni fa, con una bella prefazione di Carlo Carabba, e non se lo filò quasi nessuno, nonostante ponesse questioni cruciali), non per i suoi romanzi; autori come Guyotat e Solliers, grazie a un racconto di Roberto Bolaño uscito sul New Yorker, e mentre lo leggevo (ok, Bolaño giocava proprio su di ciò, ma tant’è) pensavo che fossero scrittori di finzione come Benno von Arcimboldi o Cesárea Tinajero.
«Rimbaud, al contrario, non mi pare un problema né un buon esempio, si legge ancora moltissimo, a tutti i livelli – e in genere circola come volume completo.»
Sì, in relazione a Rimbaud – di cui la migliore edizione che abbiamo secondo me è Opere, i Meridiani, Mondadori – hai senz’altro ragione; proprio perché ultimamente t’è capitato di occupartene – mi riferisco in particolare al tuo pezzo su La Lettura, Corsera – io ti chiedevo se avessi per caso notato parti dell’opera di Rimbaud che si leggono meno o poco. Mi fa piacere non ve ne siano.
«Io sono arrivato a Gide per vie traverse da adolescente, perché cioè talvolta come postfazione capitava vi fossero nei miei volumi di Dostoevskij saggi o porzioni di conferenze di lui. Se non viene più letto, allora certamente un testo da ricordare è I nutrimenti terrestri. Visto che m’hai fatto venire in mente i russi ottocenteschi ti chiedo se – salvi tutti gli astri del firmamento – taluni autori minori, che al proprio tempo ebbero successo in termini di pubblicazioni e influenza nel dibattito culturale, siano tutt’oggi interessanti e da frequentare. Mi riferisco ad esempio al Che fare? di Cernysevskij o a I signori Golovev di Saltykov Scedrin, ma addirittura anche ai testi non fondamentali di un Turgenev tipo Rudin o Nido di nobili.
«La letteratura russa è stata la base della mia formazione letteraria ‘adulta’, sono stato per molto tempo in fissa totale con Tolstoj, ho (non) imparato a scrivere racconti con Čechov, per un bel po’ Il maestro e Margherita è stato il mio romanzo preferito, e ovviamente ho battuto pesantemente anche le strade di Dostoevskij, Turgenev, Gogol’, Ščedrin e tutti gli altri. Ma forse proprio perché ci ho (s)ragionato così tanto, oggi la riprendo pochissimo in mano, preferisco dedicare il tempo a tappare gli enormi buchi che ho da altre parti. Gli unici due libri che continuo a rileggere sono La morte di Ivan Il’ič e Memorie dal sottosuolo. Mi interesserebbe, invece, vedere in Italia più letteratura russa contemporanea: un paio di anni fa ho incontrato Vladimir Sorokin, col suo beffardo La giornata di un opričnik e mi ha colpito molto positivamente.»
Della letteratura russa ‘classica’ quindi attualmente ti capita di riprendere in mano solo quelle due piccole perle, che si leggono in un giorno, magari durante un viaggio in treno. Sono certo – ma le mie certezze hanno il valore d’aria fritta – che in futuro sentirai il bisogno di confrontarti nuovamente almeno con i Karamazov e L’idiota, due testi pressoché inesauribili.
Vorrei chiederti, lasciando perdere l’ottocento, cosa pensi del Venedikt Erofeev di Mosca-Petruski. La ragione è duplice: mi pare un’opera per te stimolante e interessante; inoltre, anche se è abbastanza letta e diffusa, è bene parlarne – data la sua importanza – perché in molti ancora non l’hanno letta.
«È possibile che accada quel che dici con Dostoevskij: pur avendolo letto estensivamente ho avuto un rapporto che so essere stato poco profondo, probabilmente proprio perché nello stesso periodo ero completamente abbacinato da Tolstoj.
«Mosca-Petruski lo presi quando uscì, è quello con la traduzione di Nori, no? Sì è quello (sono andato a vedere su Google 🙂 ) mi piacque molto, ricordo, ma non è uno di quei libri che mi hanno cambiato la vita. Magari ci ridò un occhio adesso, grazie per averlo evocato.»
Dopo il Limonov di Carrère viene la voglia di andare a recuperare la produzione dell’autore omonimo. Trovi che l’opera di Limonov abbia un suo valore e che valga la pena leggerla? Ad esempio Eddy-Baby ti amo che ruolo può ricoprire oggi nella formazione di un autore (o di un lettore o di un letterato)?
«È proprio vero, è capitato anche a me, dopo aver letto Limonov, di pensare che quasi quasi potesse valer la pena di andare a ripescare le opere di Limonov medesimo. Ma non l’ho fatto.»
Abbiamo parlato di fantasy, voglio chiederti ora della fantascienza. La mia opinione è che – diamo per scontato e lasciamo in pace Asimov – Herbert e Simmons siano imprescindibili. Dato che in questa rubrica ricordiamo i libri aggiungo che il primo non ha scritto solo Dune e che questo testo non è che il primo di un ciclo: mentre Dune è straconosciuto e straletto lo stesso non accade con Il messia di Dune, I figli di Dune, L’Imperatore-Dio di Dune, Gli eretici di Dune, La rifondazione di Dune – libri che invece son portatori di suggestioni e visioni di grande potenza e che secondo me meritano di essere letti. Secondo te?
«Ai tempi dell’adolescenza fui assolutamente entusiasta di Dune, ma mi arenai poi a metà del secondo libro, attratto da chissà cos’altro. Recentemente l’ho ripreso in mano perché lavorando alla conferenza su psichedelia e letteratura che ho portato un po’ in giro tra festival, librerie e università, ho scoperto che Herbert aveva scritto tutto il libro mantenendosi costantemente sotto effetto di funghi psilocibinici, e parlando di ciò il collega e amico Edoardo Nesi mi ha consigliato di cercarmi appunto L’Imperatore-Dio di Dune, che ai tempi non avevo letto: devo dire che l’ho apprezzato molto.»
Visto che siamo in tema ti voglio fare una domanda sulla scrittura stimolata da sostanze psicotrope e stupefacenti. Non mi interessa molto un dotto elenco di autori che ne hanno fatto uso, voglio chiederti invece quali sono dal tuo punto di vista per un autore contemporaneo o addirittura per un esordiente le criticità, le problematiche, le potenzialità e i rischi – letterari, non sanitari, naturalmente – dell’utilizzo di questa tipologia di molecole ai fini esclusivi della scrittura in concreto.
«Premesso l’ovvio, ovvero che l’apertura delle porte della percezione non può che giovare a chiunque stia intraprendendo una ricerca (e la scrittura lo è sempre), la conferenza di cui sopra partiva proprio da una domanda: perché la rivoluzione psichedelica, che in altri campi come la musica, il cinema o le arti visive (per non parlare della biologia, dell’informatica o della fisica teorica), aveva avuto effetti immediati e, appunto, rivoluzionari, in letteratura ne aveva avuti invece di relativamente ridotti e comunque tardivi? Pensa a quanto è in fin dei conti tradizionale un romanzo come Qualcuno volò sul nido del cuculo di Ken Kesey, uno dei padri stessi della rivoluzione psichedelica coi suoi Merry Pranksters (ottimamente raccontati da Tom Wolfe nel suo The Electric Kool-Aid Acid Test), o al fatto che il libro forse più direttamente influenzato nella struttura e nelle modalità narrative dall’LSD (nonché capostipite di tutti quei romanzi cosiddetti ‘massimalisti’ che, nota bene, dalla psichedelia hanno preso un nuovo approccio alla struttura generale, più che temi, stile o modalità di costruzione della frase o della pagina), L’arcobaleno della gravità  di Thomas Pynchon, arriva solo nel ’73. Il discorso meriterebbe maggior spazio e approfondimento, ma credo che c’entri il fatto che la letteratura è, tra le arti, quella più dipendente dal proprio stesso canone: quando scrivi un romanzo, lo stai inevitabilmente scrivendo seduto su una infinita ziggurat fatta dai libri che sono venuti prima, e in simili condizioni la noesi, la conoscenza intuitiva, l’accesso a una realtà acategorica, finanche la rivelazione mistica, sono molto meno utili rispetto ad altre arti.»
di Thomas Pynchon, arriva solo nel ’73. Il discorso meriterebbe maggior spazio e approfondimento, ma credo che c’entri il fatto che la letteratura è, tra le arti, quella più dipendente dal proprio stesso canone: quando scrivi un romanzo, lo stai inevitabilmente scrivendo seduto su una infinita ziggurat fatta dai libri che sono venuti prima, e in simili condizioni la noesi, la conoscenza intuitiva, l’accesso a una realtà acategorica, finanche la rivelazione mistica, sono molto meno utili rispetto ad altre arti.»
Circa la produzione di Simmons mi stanno particolarmente a cuore il ciclo dei Canti di Hyperion e il ciclo Ilium/Olympos. Vorrei chiederti cosa pensi di queste opere e quanto attualmente vengono lette. Ti chiedo inoltre di indicare quali autori di fantascienza – più o meno noti e presenti nel discorso letterario attuale – siano meritevoli di essere ricordati e letti
«Fu Wu Ming 2 a consigliarmi il ciclo di Hyperion diversi anni fa e gliene sono grato: davvero imprescindibile. Non sono un grandissimo esperto di fantascienza, e non so quanto mi piacerebbe oggi quella che leggevo da ragazzino, che so Sterling, Gibson… Quindi immagino che i miei consigli sarebbero ovvi, vale la pena spendere una riga per dire che bisogna leggere Philip Dick? Ok facciamolo: si legga Philip Dick, specialmente Ubik e Questo oscuro scrutare. Anzi, lo si legga tutto. Ah e Stanisław Lem, naturalmente. Altri mi piacciono più come saggisti, penso a 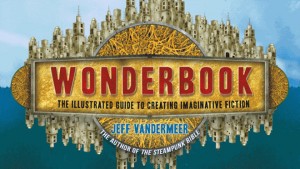 Ursula K. LeGuin o a Jeff VanderMeer, bellissimo e anche divertente il suo libro di narratologia Wonderbook, mentre la trilogia dell’Area X, pur bella, sembra un pezzettino o uno spin-off semplificato del secondo o del terzo volume di Abbacinante, così come, per prender un libro che può essere ascritto al genere steampunk, ancorché colto e iperletterario, il pur ottimo The underground railroad di Colson Whitehead, che tanti onori ha raccolto in patria, può essere visto – al netto del tema razziale e della sensibilità con cui è trattato – come qualcosa che già ampiamente contenuto, con totale understatement, nell’opera di Pynchon; anche per questo oggi mi interessano più le grandi opere che cercano di contenere anche i generi senza piegarvisi che gli ultimi sviluppi dei generi in sé.»
Ursula K. LeGuin o a Jeff VanderMeer, bellissimo e anche divertente il suo libro di narratologia Wonderbook, mentre la trilogia dell’Area X, pur bella, sembra un pezzettino o uno spin-off semplificato del secondo o del terzo volume di Abbacinante, così come, per prender un libro che può essere ascritto al genere steampunk, ancorché colto e iperletterario, il pur ottimo The underground railroad di Colson Whitehead, che tanti onori ha raccolto in patria, può essere visto – al netto del tema razziale e della sensibilità con cui è trattato – come qualcosa che già ampiamente contenuto, con totale understatement, nell’opera di Pynchon; anche per questo oggi mi interessano più le grandi opere che cercano di contenere anche i generi senza piegarvisi che gli ultimi sviluppi dei generi in sé.»
Vorrei sapere qualche cosa di più sul tuo retroterra culturale personale, mettendo un secondo da parte la letteratura propriamente detta; mi interesserebbe in particolar modo sapere quali sono state le correnti filosofiche, gli autori e le opere che maggiormente t’hanno aiutato a svilupparti, che più t’hanno occupato, che più ami e hai amato.
«Non sono sicuro di poter parlare di ‘sviluppo’: ai tempi del liceo da noi si studiava storia della filosofia, più che filosofia, e in ogni caso non ero uno studente puntiglioso; né leggevo filosofia ai tempi dell’università: avevo appena riscoperto il romanzo e mi dedicavo a quello (ogni tanto, ma solo agli ultimi anni, studiavo anche, e ricordo con piacere Durkheim, Weber, Horkheimer&Adorno, Giddens…). Ne consegue che tutto ciò che ho letto, studiato e amato in filosofia viene dopo. Posso farti una lista di ‘preferiti’, che so, Thoreau, Plotino, Eraclito, Spinoza,  Wittgenstein, Agostino, Lao Tzu, Proudhon, Nietzsche, Freud (Groddeck, col suo Libro dell’es, lo lessi invece da bambino e mi colpì molto, così come L’arte della guerra di Sun Tzu, altro testo imprescindibile della mia infanzia), Jung, Foucault, De Beauvoir, Bey, Weil, Debord, Deleuze&Guattari, ma in realtà, come ti dicevo, sono tutti pensatori che ho scoperto, e in alcuni casi approfondito, quando ero già adulto – la lista stessa basta a indicare che li ho scoperti in modo disordinato. Idem per Sutra del Loto, Rg Veda, Vangeli, Bhagavad-gītā, per citare quattro testi sacri che amo molto: tutte cose scoperte e approfondite dopo i venticinque. Il Libro dei mutamenti, o I-Ching, invece, sebbene non sia esattamente né un testo sacro né un testo filosofico, lo beccai da ragazzino e mi impressionò moltissimo – in effetti mi impressiona ancora, ogni giorno.»
Wittgenstein, Agostino, Lao Tzu, Proudhon, Nietzsche, Freud (Groddeck, col suo Libro dell’es, lo lessi invece da bambino e mi colpì molto, così come L’arte della guerra di Sun Tzu, altro testo imprescindibile della mia infanzia), Jung, Foucault, De Beauvoir, Bey, Weil, Debord, Deleuze&Guattari, ma in realtà, come ti dicevo, sono tutti pensatori che ho scoperto, e in alcuni casi approfondito, quando ero già adulto – la lista stessa basta a indicare che li ho scoperti in modo disordinato. Idem per Sutra del Loto, Rg Veda, Vangeli, Bhagavad-gītā, per citare quattro testi sacri che amo molto: tutte cose scoperte e approfondite dopo i venticinque. Il Libro dei mutamenti, o I-Ching, invece, sebbene non sia esattamente né un testo sacro né un testo filosofico, lo beccai da ragazzino e mi impressionò moltissimo – in effetti mi impressiona ancora, ogni giorno.»
Ti chiedo di indicare tre autori italiani, attualmente poco o punto letti, che secondo te valga la pena recuperare e perché. A me son venuti in mente Un uomo finito di Papini, Dino Campana e L’Alcibiade fanciullo a scola di Antonio Rocco (lo dico in modo tale da espormi io per primo, ma ovviamente interessante è la tua di risposta).
 «Sicuramente ti vengo dietro su Papini. Imprescindibile. Dire Malaparte è una banalità? Si trova continuamente citato per Maledetti toscani, uno dei suoi libri più leggeri, ogni tanto per La Pelle, ma rarissimamente per Kaputt, che invece è un capolavoro. Fino a qualche anno fa avrei detto pure Cristina Campo, ma mi pare che oggi, anche grazie all’azione di Adelphi, sia tornata a ricevere delle attenzioni. Andando a scavare un po’ più sotto, negli anni scorsi ho incontrato, e trovato molto interessanti, Cristi polverizzati di Luigi Di Ruscio, L’ultima erranza di Giuseppe Occhiato e Sinfonia di Antonio Pizzuto.»
«Sicuramente ti vengo dietro su Papini. Imprescindibile. Dire Malaparte è una banalità? Si trova continuamente citato per Maledetti toscani, uno dei suoi libri più leggeri, ogni tanto per La Pelle, ma rarissimamente per Kaputt, che invece è un capolavoro. Fino a qualche anno fa avrei detto pure Cristina Campo, ma mi pare che oggi, anche grazie all’azione di Adelphi, sia tornata a ricevere delle attenzioni. Andando a scavare un po’ più sotto, negli anni scorsi ho incontrato, e trovato molto interessanti, Cristi polverizzati di Luigi Di Ruscio, L’ultima erranza di Giuseppe Occhiato e Sinfonia di Antonio Pizzuto.»
Noto che il rapporto con l’antichità classica s’è sfilacciato a partire dalla mia generazione, per poi compromettersi totalmente nella generazione successiva. L’approccio o è specialistico – il filologo, il latinista, il grecista – o tende a non essere affatto: ironia e ignoranza ostentata; inutili orpelli disseccati, detriti retorici della formazione più grettamente scolasticistica; diffusi il vanto di sbattersene e il richiamo vuoto di maniera.
A me interessa invece la reale fruizione diretta (anche in traduzione) dei testi, mi interessa la lettura viva: trovo che ci sia tutt’ora la possibilità di trarne godimento e arricchimento, tanto per un lettore quanto per un autore.
In questo ambito i miei preferiti sono Erodoto, Plutarco (in particolare Le vite parallele di Alessandro e Cesare, Demostene e Cicerone, Nicia e Crasso, Alcibiade e Coriolano, Temistocle e Quinto Fabio Massimo), Diogene Laerzio, Petronio, Livio, Tacito e Svetonio. Aggiungo poi gli epistolari – l’uno gli antipodi dell’altro per composizione e scopo – di due giganti che per il resto ben poco m’hanno dato: le Lettere a Lucilio di Seneca e quelle ad Attico di Cicerone. Tu in che rapporti stai con questa gente? Per quale motivo un ragazzetto che vuole scrivere dovrebbe leggerli?
«Il motivo è implicito nella domanda, è fin banale ricordare che nei classici greci e latini c’è tutto… Amo Ovidio e i grandi tragici greci, mi piacciono Marziale e Virgilio, ma la verità è che si tratta di una ferita aperta, perché mi piacerebbe avere il tempo necessario per conoscere meglio questi autori, quelli che citi e tutti gli altri, o addirittura per studiare greco e latino onde leggerli in originale, e so che è impossibile visto che ci vorrebbe un’altra vita.»
Vanni, ha senso ricordare i libri? Ha senso colmare le proprie lacune anche se si ha un’ottima cultura? Ha senso riprendere in mano testi che non sono all’ordine del giorno dell’opinione pubblica colta e del dibattito intellettuale e culturale? Ha senso andare a frugare tra i libri che non interessano più a nessuno se non a un conclave settoriale di eruditi specializzati? Ha senso costruirsi dei percorsi di lettura autonomi che vadano a scavare anche in ciò che l’oblio s’accinge a divorare? Tu come costruisci i tuoi percorsi di lettura?
«Sì, sì, sì (x5). La letteratura, la sua perpetrazione se vogliamo, funziona anche grazie a tali processi, tanto più in un’epoca in cui il mercato scompagina le carte e gli editori sono a volte costretti a far credere che siano buoni gli autori che vendono, piuttosto che sforzarsi per vendere meglio quelli davvero buoni. Presente quel passo di 2666 in cui Pelletier si commuove perché a un oscuro convegno all’università di Santa Teresa arrivano degli studenti messicani che avevano sentito parlare di Benno von Arcimboldi? Bene, anch’io credo che finché ha almeno un lettore appassionato, un libro è vivo, e dunque, sì, fare ciò che elenchi ha senso, è utile, è necessario, anche quando sembra di parlare al vento: non si sta mai, in realtà, parlando al vento – e vale tanto più oggi che Internet ha reso più semplice indagare autori che sono stati fin lì solo un sentito dire o nemmeno quello, scovarne i volumi, scoprire se qualcuno ne ha scritto, scriverne, parlarne in un’intervista…
«Circa i miei percorsi: mi sono sempre mosso, si sarà capito, per chiazze. Identifico zone (termine inteso indifferentemente nel senso di singoli autori, filoni, periodi, temi) in cui sono scoperto, acquisto un blocco di libri, li leggo, se nasce ulteriore interesse approfondisco, altrimenti passo a una nuova ‘chiazza’. Negli anni, a forza di leggere, questo movimento, iniziato in modo sostanzialmente casuale (ricordo che nel 2001, quando ero ancora distante dall’idea di scrivere ma mi era appena tornata addosso una virulenta frenesia di lettore, mi feci regalare per Natale da mia madre 500 euro di libri con cui cominciai a ‘tappar buchi’) ha acquisito una sua armonia. Ciò avviene in contemporanea a percorsi più lineari, riassumibili nel cercare di seguire le novità più interessanti italiane e estere, nel continuare a studiare filosofia e nel completare la conoscenza degli autori che già amo.»
Concludendo, alla luce di questo articolato discorso che abbiamo fatto, voglio tornare al principio e chiederti (vista la tua esperienza e preparazione in materia): questa rubrica ha ritenuto stimolante andare a iniziare a mappare quasi a campione – a carotaggio – il territorio dell’onirico, nel sacro, del visionario, dello psichedelico, del mistico, del religioso, dell’apocalittico: a te chi viene in mente che possa essere curioso andare a indagare nella stessa – di per sé vastissima e addirittura spaesante – direzione?
«Visto che questa intervista ha preso i contorni anche di un prisma che lancia raggi verso nuove possibili letture, ti rispondo anzitutto con due articoli, anzi tre: uno di Gianluca Didino su Kermode e le narrazioni dell’apocalisse; uno di Edoardo Camurri su acido lisergico e Finnegan’s wake; e infine, per una delle tante possibili implicazioni di tutto ciò (scelgo questo visto che è un’ipotesi già considerata, prima che dagli scienziati di oggi, da teoreti psichedelici come Leary e McKenna e soprattutto da molti autori di fantascienza), un pezzo di Roberto Paura sulla possibilità di trovarci in un universo simulato. Detto, o meglio linkato, ciò, aggiungo che l’attuale momento storico è interessante perché, grazie a un contemporaneo sdoganamento scientifico e culturale, si sta sollevando quella cappa oscurantista che tendeva a vedere gli psichedelici come chincaglieria anni ’60, nel migliore dei casi, o come pericolo per la gioventù nel peggiore, assimilandoli al generico calderone delle droghe (accusa tanto più risibile se si pensa che venivano e vengono usati nella cura delle dipendenze), e finalmente tornano a essere visti come un possibile strumento conoscitivo. Il 19 aprile 1943, col ‘bicycle day’, siamo entrati nella cosiddetta era della riproducibilità tecnica dell’esperienza mistica, e il grosso dei frutti di tale salto di paradigma deve ancora essere raccolto, dato che dopo l’accelerata troppo brusca degli anni ’60 ci fu la ben nota frenata, e un periodo di reazione durato fino a oggi. Stanno uscendo così tanti libri che è diventato addirittura difficile seguirli tutti – chi lo vuole fare può affidarsi all’ottimo portale inglese Psychedelic press –; da parte mia, oltre agli ovvi Hofmann, Leary (da recuperare il suo Il gran sacerdote, di notevole interesse anche fuori dal contesto storico in cui nasceva) e Alpert/Ram Dass, sempre attuali, e a teoreti più recenti ma validi come Naranjo, Pinchbeck o Strassman, trovo che sia sempre proficuo tornare ai classici, sia più celebri, come Burroughs, Ginsberg (pensa alle loro Lettere dello yagé, scritte quando nessun occidentale aveva mai sentito parlare dell’ayahuasca) o il da te citato Huxley, sia più sotterranei: di recente mi sono procurato Visit to Godenholm, prima traduzione inglese di Besuch auf Godenholm il  libro di Jünger più direttamente influenzato dalle sue esperienze lisergiche, l’amico Simone Caltabellota mi ha passato l’interessantissimo Krautrocksampler di Julian Cope, mentre a Parigi è stato fin troppo semplice mettere le mani su Miserable miracle del sopracitato Henri Michaux, che ebbe il merito di scrivere testi minuziosi sul tema ben prima dell’esplosione delle estati dell’amore. Da riprendere è senz’altro anche The Great Shark Hunt di Hunter S. Thompson, raccolta dei suoi articoli da ‘gonzo journalist’, che ben mostra quanto l’autore andasse oltre il pur adorabile personaggio perennemente in botta in cui lo ha trasformato e eternizzato il suo Paura e delirio a Las Vegas.»
libro di Jünger più direttamente influenzato dalle sue esperienze lisergiche, l’amico Simone Caltabellota mi ha passato l’interessantissimo Krautrocksampler di Julian Cope, mentre a Parigi è stato fin troppo semplice mettere le mani su Miserable miracle del sopracitato Henri Michaux, che ebbe il merito di scrivere testi minuziosi sul tema ben prima dell’esplosione delle estati dell’amore. Da riprendere è senz’altro anche The Great Shark Hunt di Hunter S. Thompson, raccolta dei suoi articoli da ‘gonzo journalist’, che ben mostra quanto l’autore andasse oltre il pur adorabile personaggio perennemente in botta in cui lo ha trasformato e eternizzato il suo Paura e delirio a Las Vegas.»
Vanni Santoni* (Montevarchi, 1978) vive a Firenze. Dopo l’esordio con Personaggi precari ha pubblicato, tra gli altri, i romanzi Gli interessi in comune (Feltrinelli 2008), In territorio nemico (minimum fax 2013, da coordinatore), Se fossi fuoco, arderei Firenze (Laterza 2011), Terra ignota (Mondadori 2013), Terra ignota 2 – Le figlie del rito (Mondadori 2014), Muro di casse (Laterza 2015).
Scrive sul Corriere della Sera e su altre testate come Internazionale e Vice; da tre anni dirige la narrativa Tunué, affermatasi come una delle principali fucine di nuovi talenti. Il suo prossimo romanzo, La stanza profonda, uscirà per Laterza nella primavera 2017.
Disclaimer: immagini prese dal web.

