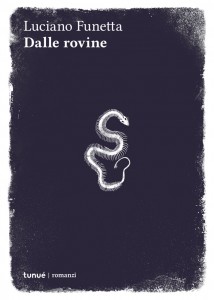 Dalle rovine | Luciano Funetta
Dalle rovine | Luciano Funetta
Tunuè Edizioni
Una delle cose che considero ammirevoli in una scrittura è la forza evocativa, la possibilità di farti abbandonare il qui e ora e recuperare passaggi dalla memoria. Ora questo non ha nulla a che vedere con una recensione che si rispetti, in cui si dovrebbe iniziare con il parlare dei contenuti del libro, e invece mi sento di iniziare dal sentimento che la lettura di Dalle rovine ha sin da subito determinato: inquietudine e ricerca di riferimenti filosofici e ideologici, che potessero risolvere lo straniamento che si genera quando sai che stai per fare un viaggio negli spigoli dell’umanità.
Alla memoria torna l’incipit di Memorie dal sottosuolo (F. Dostoevkij), “io sono una persona malata – io sono una persona cattiva. Io sono uno che non ha niente di attraente …”
Ebbene, in queste opere, ci troviamo da subito impossibilitati ad evitare l’angosciante sensazione di andare troppo vicino alla “verità terribile”.
Ed è ciò che si avverte nella narrazione ipnotica di un “sottosuolo” dell’anima che è Dalle Rovine, in cui siamo trasportati da una luce al neon, fredda, essenziale e chirurgica. Tutto avviene in un luogo desertificato come i sentimenti dei suoi abitanti e dei protagonisti, in un tempo che potrebbe essere tutti i tempi.
Un romanzo “alto” , potente e colto, in cui le parole tagliano, sezionano, creano iati dove manca il respiro, le descrizioni amplificano il senso di “tetro” e “squallore”. E tuttavia un altro sentimento si affianca all’imbarazzo di comprendere che si tratta della periferia emozionale di una città qualunque – simbolo delle strade dei nostri intimi bassifondi – ed è l’inesorabilità degli eventi, che accadono nel rigore della calma, nell’atarassia, nel malgoverno delle meschinità e dell’orrore. Questo “accade”. Il male non si ferma quasi mai.
Rivera, il protagonista principale condivide la sua vita con trenta serpenti, stipati in altrettante teche, e che alleva con cure amorevoli e puntuali, peraltro da esperto, in un anonimo appartamento della zona Nord di Fortezza località immaginaria. Abbandonato dalla famiglia scandisce il suo tempo tra il nulla e la manutenzione delle teche. I serpenti saranno il suo accesso al mondo della pornografia e alla conoscenza di registi e sceneggiatori di snuff movies che lo coinvolgono in un progetto crudele e ossessivo.
Tutta la storia viene narrata come fosse filmata in presa diretta da un “Noi” narrante che non solo è onnisciente ma è onnipresente fino ad arrivare all’interazione in scena con il protagonista stesso che a questo “Noi” per un attimo si rivolge.
Quale sia l’esigenza di un “Noi” lo si può solo supporre, e tra le ipotesi a me è piaciuto pensare che il “Noi” sia il resto del mondo che poi spegnerà lo schermo di quel film allucinato, e si occuperà della quotidianità fatta di lavoro, casa, figli e la certezza dell’esistenza del “bene”.
Si diceva del senso di inquietudine che si avverte dalle prime pagine:
[…] Avevamo incontrato Rivera per caso, durante una tetra notte di squallore in cui anche noi vagavamo tra le ombre, e ci era sembrata la creatura più diffidente della terra. Ne eravamo rimasti colpiti e avevamo iniziato a seguirlo. Adesso, dentro il cinema domestico di Jack Birmania, ci sembrò che per Rivera non potesse esistere luogo più sicuro di quella casa nascosta tra gli alberi, il museo in cui si custodiva l’archivio eterno della pornografia, un mondo di cui non sapeva nulla, brancolava nel buio, beveva il liquore di Birmania e guardava l’ultimo film di un regista che aveva deciso di realizzare il suo capolavoro e il suo suicidio.
A questo si aggiunge l’idea che ognuno di noi possa sperimentare stanze recondite di sé, che lo rendano un “terminale” della coscienza:
[…] Perdonami se ti do del tu, ma mi ricordi di quando avevo la tua età. Anch’io ero un terminale, rovistavo tra le immondizie come se fossero mazzi di fiori profumati.
Tale condizione di “non-adattivo” l’uomo (Rivera) la vive in uno stato di isolamento esistenziale dove i “serpenti” riescono ad abitare ogni sorta di relazione (persino quella sessuale), con l’idea chiara, tuttavia, che tale condizione sia condivisa da molti, moltissimi:
[…] perché in qualche modo il film aveva a che fare con la moltitudine, con la forza spietata della moltitudine e con la segretezza della solitudine, con le allucinazioni e gli incantesimi provocati dalla solitudine.
A tutto questo deserto interiore, il romanzo di Funetta non sembra offrire alcuna finestra di salvezza, se non nell’idea che si abbia la necessità ora di una sorta di “destrutturazione ” :
Bisogna cambiare registro» […] «Tornare alle origini, a quando l’arte e la fame erano la stessa cosa. Dobbiamo essere uomini che dipingono scene di caccia in una grotta, affamati che cacciano e disegnano nello stesso momento e con i medesimi strumenti»
Altro elemento di rilevanza stilistica e strutturale è il frequente ricorso al “sogno”. Un sogno che prima di tutto viene invocato come soluzione di annichilimento:
[…] Ma Rivera non sentì nulla. Pensava ai serpenti, ne sentiva la mancanza. Voleva solo tornarsene a casa per baciarli, curarli, nutrirli, togliersi di dosso quei vestiti e mettersi a leggere davanti alla finestra aperta della sua stanza, addormentarsi e sognare. Un sogno senza esseri umani e senza musica, un sogno ambientato in una città diversa da Fortezza, magari un sogno senza di noi, un sogno vuoto che nessuno aveva mai osato sognare.
Poi i sogni scandiscono punti nodali dell’intreccio: tutti sognano e riferiscono di sogni fatti, fino a che le realtà (vera e onirica) si sovrappongono più volte, come estensioni una dell’altra.
Non troviamo, a mio avviso, sogni in funzione “di coscienza” come in Delitto e Castigo, dove Raskol’nikov vive il nucleo di un tormento individuale, dialettico tra la realtà e l’immaginario, e dove il sogno sviluppa simbolismi e trame speculari che consentono la portata in avanti del vissuto.
Qui invece il sogno è un “fatto” che avviene come necessario alla scena, una delle cose che devono accadere. Inesorabili.
Da ultimo una considerazione sui sentimenti “di amore”, il romanzo ne è privo cosa che contribuisce ad incrementare la durezza e la crudeltà del buio che ci viene raccontato, tuttavia l’umana pietas appare possibile anche al protagonista, che incapace di amore e affetto, tanto che non si muove a commozione per la perdita della famiglia preferendo i serpenti a moglie e figlio, si intenerisce da ultimo per le sofferenze causate dalla malattia del vecchio produttore cinematografico in fase terminale:
Ti porto io» disse Rivera, e senza aspettare che Traum rispondesse lo afferrò dolcemente per le ascelle e lo issò in piedi. Poi gli passò una mano dietro la schiena, l’altra dietro le ginocchia e lo sollevò. Quel mucchietto di pelle rinsecchita non pesava nemmeno cinquanta chili. Seguimmo Rivera lungo le scale con il suo fragile fardello, poi attraverso il corridoio in penombra fino alla porta della stanza. Quando entrammo, lo vedemmo depositare con cura il corpo di Traum sulla branda.
Non vi ho letto tuttavia in questo alcuna resurrezione, redenzione o “autenticità” dell’atto. Anche questo deve accadere e accade. Rivera non ha una “coscienza” che qualifica il gesto in bellezza, ha un comportamento artificiale e sistematico. All’interno di un processo vitale che contempla il male, la tortura come piacere voyeuristico, la morte data per “opera” artistica in pasto a perversioni lugubri e daimon infetti, qualsiasi atto d’amore è solo un meccanicismo non salvifico.
Dalle Rovine è una prova eccellente di questo giovane autore che lascia intravedere una formazione letteraria solida, una capacità di linguaggio personale e incisivo e merita la candidatura al premio Strega.
Nota biografica:
Luciano Funetta, classe 1986, vive a Roma. Fa parte del collettivo di scrittori TerraNullius. Ha pubblicato racconti su WATT, Granta Italia, Costola e altre riviste. È tra gli autori di Dylan Skyline – dodici racconti per Bob Dylan (Nutrimenti, 2015).

