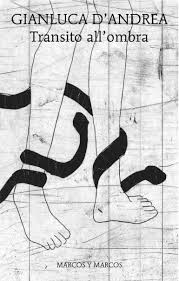 Transito all’ombra | Gianluca D’Andrea
Transito all’ombra | Gianluca D’Andrea
Marcos y Marcos, 2016
Recensione di Gabriele Belletti
«Recando passati e passando»:una resa in visione del mondo
L’esergo (p. 9) che apre la raccolta di Gianluca D’Andrea, Transito all’ombra (Marcos y Marcos, 2016), dichiara, quasi fosse brano di poetica esplicita, un’intenzione. L’autore lascia infatti a Mandel’štam il compito di esprimere il suo (primo) pensiero e, con esso, la sua volontà: la rinuncia a considerare un destino e una storia come meramente personali e optare per un procedere distante da chi «l’ombra sua non cura», capace invece di attraversare l’ombra stessa, evitando il «niente» in cui le parole potrebbero finire («le parole finiscono nel niente / oppure si agganciano in noi», Cambriano, p. 62).
Il transito prende effettivamente le mosse nella prima sezione, La storia, i ricordi, dove il soggetto, con la sua voce, si disloca in un passato stratificato, per riportare nel presente, in anni «‘serraturizzati’ a blocchi» (XII, p. 34), un canto da tempo interrato. Chi lo canta, infatti, si reca in una posizione di retroguardia rispetto all’oggi in cui vive e attraverso cui, lente, interpreta ciò che è stato (dinamica questa che ricorda per certi aspetti il D’Ormesson de Le rapport Gabriel). Da una tale postazione, l’autore ri-porta ricordi assemblati in paesaggi individuali e collettivi, ricostruisce e si ricostruisce scavando in un humus comune. L’assemblaggio permette di ricomporre anche un noi-agglomerato («ci riconoscevamo negli scoppi», I, p. 14), una sorta di comunità coetanea e giocosa, colta in formazione col soggetto in un contesto mutevole («Il gioco già mutava in clangore», IV, p. 18), in cui sono spesso altri, dall’alto, a decidere («Aprivano e chiudevano le frontiere», X, p. 30).
L’io si muove in una rete di «ricordi improvvisi» (V, p. 19) – in cui l’attuale Rete non era ancora presente – producendo una poesia vivacemente geologica (ma non fossile). In essa è incarnata una riflessione sulla natura della storia (collettiva) e dei ricordi (individuali) dell’autore e dei lettori che come lui hanno fatto esperienza di quei paesaggi. Allo stesso tempo – e qui si ravvisa una prima intenzione pedagogica – il soggetto rimembrante allestisce il suo transito di fronte alla nuova generazione che questa rete non afferra – ma è afferrata già dall’altra Rete.
Un tale procedere non può tralasciare – in un atto di onestà rispetto al proposito iniziale – la messa in discussione della natura del soggetto di emissione e della sua stessa voce, con l’intento di eludere qualsivoglia individualismo. Il Primo dittico si presenta così come una sorta di epistemologia della voce poetica. Nel primo dei due testi che lo compongono si esalta un “io-nucleo” che, agendo, diviene se stesso («io sarà il nucleo / per cui posso essere me stesso», Trasposizione (o l’identità del poeta), p. 37). Il poeta-padre riceve il motivo di un tale fare poesia dalla figlia – come è confermato anche in diversi luoghi della raccolta. Questa bambina che pedala («Mia figlia pedala», Ibidem) indica l’importanza dell’azione e del sentire, della compromissione con l’esperienza che porterà il genitore fino all’ustione e a una continua e doverosa trasposizione («ustionato da tutti i contatti», Ibidem). Il tempo presente e il tempo futuro di questa prima lirica paiono suggerire l’attuale scelta dell’autore, distante dall’imperfetto di una condizione superata, oggetto del secondo componimento, L’identità (o trasposizione del poeta, p. 38). Lì l’io si trova(va) in contatto perenne con sé stesso, tanto da non poter avanzare – nessun «triciclo» qui – ma solo calpestare «i propri passi».
Ciò che è cantato nel dittico si fa propedeutico anche al prosieguo della silloge. Nella sezione successiva, Immagini, i ricordi, composta da un museo di «quadri di vita quotidiana» (Nota dell’autore, p. 104), il «nucleo» soggettivo sente e agisce («mi muovo», La storia dell’immagine, p. 41), accumulando immagini e ricordi polimorfi, fatti di sensazioni scomponenti («l’odore sfalda il racconto», Visuale, p. 46) e ricomponenti («Treviglio sfuma dal fuoco delle voci / e diventa un film sottile», Altro viaggio, p. 48). Non sono però, come si diceva, ricordi intrappolati, fossilizzati, tutt’altro. Essi possono addirittura agire, dando vita ad accensioni momentanee («i ricordi si accendono in istanti», «si accendono ricordi e passioni», Il fuoco (ritorno in Sicilia), p. 49) e tangendo concretamente il presente («un ricordo cola materia / sul presente», Autunni d’interno (o Cubismi), p. 53). Nel muoversi e trasporsi nelle trame dei «quadri» esposti, il soggetto forma il suo sguardo inevitabilmente “cubista”, conscio della «diversificazione che ogni spostamento può produrre» (Note, p. 104) e che «lo spostamento / si concretizza in gesti, / in azioni sensibili» (Cambriano, p. 62).
Nel corso della composizione inter-dimensionale, la bambina torna a presentarsi, confermandosi soggetto privilegiato delle riflessioni poetiche del padre (la figura di Sofia ricorda, sia per il cubismo sotteso sia per la relazione autore-figlia, la Paloma picassiana). Anche lei è parte del transito del poeta ed è come lui toccata dal cambiamento e dalle circostanze, indispensabili per divenire quel che si è. Alla luce dell’universalità e inevitabilità della trasposizione, il poeta non può far altro che ammettere una sicura «resa» che, però, non è da intendersi solo come un arrendersi di fronte al cambiamento, ma anche come possibilità della poesia di “rendere” («la lingua diventa l’eco di un campo», La resa, p. 44), restituire una visione consapevole (Visione, p. 46) dei movimenti categoriali implicati (Temporale estivo, pp. 50-51). La (p)resa in visione del mondo attraverso il linguaggio della poesia pare allora scelta gnoseologica atta a rendere conto di un fitto e precario reticolo di ombre e moniti luminosi («Mi ripeto la vita della luce / è la legge da noi non preparata, / un monito che si può accompagnare / ai gesti quotidiani», L’altra immagine, p. 52), ma anche a educare a valori imprescindibili («osserva tanto», «ciò che senti ricordalo», Lettera a mia figlia, p. 63).
Dopo aver iniziato poeticamente il lettore alla complessità della visione, il soggetto osa avvicinarsi in maggior misura alla propria quotidianità, riuscendo ad evitare – ancora per coerenza alle intenzioni iniziali – il possibile sconfinamento nel privato racconto di sé. In Era nel racconto (titolo della quarta sezione), infatti, pur denunciando passati ombrosi, rimasti “in potenza” o transitori – passati che hanno toccato la sua stessa biografia – egli non rinuncia a cogliervi motivi e moniti universali, che si presentano sotto forma di luminose speranze (Zingonia, p. 59) o di fiducia nelle relazioni umane («Ricordo / la possibilità di relazione e le persone conosciute» (Concorso (e alla fine, la fine del mondo), p. 60). A cucire relazioni e legami è un fiato poetico messo al servizio del ricordo, un fiato-filo che unisce nonostante la consapevolezza della fragilità / mutevolezza dei legami, siano essi inter-dimensionali, inter-personali, inter-generazionali (Gli alberi, i ragazzi, pp. 64-68) e inter-spaziali (VI. Braccare lo spazio, Giotto, pp. 76-80).
Anche tra Zone recintate (altra sezione della raccolta) questo fiato non cessa di creare legami. Il soggetto che lo emette, qui trasposto tra monumenti e luoghi visitati, varca e canta confini mobili («ho arricchito il mio confine, / ho perso il mio confine», Errare, un urlo, p. 75, «confini malleabili», IV. Trento, in Europa, p. 74), mentre Sofia, indifferente alle colte stratificazioni imbastite dal padre (Perugia (sud), p. 83), ancora una volta indica un suo modo possibile di transitare in quelle zone. La bambina, infatti, non vuole e non può essere addomesticata dalla Storia, rilascia il suo urlo per le strade come monito di indipendenza («Mia figlia urla / per le strade», Trieste, Lubiana, p. 77), «come volesse / uscire dal mondo», V. Errare, un urlo, p. 75). Gli impulsi im-mediati a cui lei si affida – rimandanti a elementi elettronici, ma anche fisiologici – apparentemente senza storia, ma vivi nello stesso tempo del genitore, producono legami dalla natura più effimera e rapida, dove la luce di uno «schermo microscopico» (VIII. Perugia (sud?)) – ultima “zona recintata” – si impone con crudele giocosità su dimensioni più “lente” e maestose.
La raccolta si chiude col prevalere, solo apparente, dell’ombra, di cui si riempiono i componimenti Notturni. L’autore termina il suo canto e si raggruma riflettendo nella sua propria casa, al termine del suo quotidiano transito. È compito ancora della bambina, qui addormentatasi, di chiamare il padre a riconsiderare il suo stare. Mentre il genitore la guarda e la canta («un altro sguardo / alla bambina addormentata», II, p. 92), lei riesce a far intravedere una via di fuga dagli strati complessi e mondani, a richiamare il padre alla resa nel suo sonno senza storia, leggero e, a suo modo, luminoso.
Gabriele Belletti (1980) è originario di Santarcangelo di Romagna. Si è laureato in filosofia a Bologna con una tesi sull’estetica di Luciano Anceschi, e ha poi conseguito il dottorato in Lingua e letteratura italiana a Nantes, dove ha vissuto e insegnato per alcuni anni. Vive ora a Namur, in Belgio. Dopo alcune pubblicazioni in rivista e alcune plaquettes, il suo libro d’esordio, Krill, è apparso nel 2015 per le edizioni milanesi Marcos y Marcos.

